Johann Wolfgang Goethe e la religione
 Una scena del dramma di Goethe: Faust passeggia con Margarita, parlando di religione
Una scena del dramma di Goethe: Faust passeggia con Margarita, parlando di religione
Quadro di Hendrik F. Schaefels (1863).
fonte:
Wikimedia CommonsIl dialogo tra Faust e Margherita:
Nel "Faust", l'opera principale di Goethe, c'è una celebre scena in cui Margherita, innamorata di Faust (che si presenta come Enrico), vuole capire meglio se questo personaggio ha delle intenzioni serie con lei o no. Il dialogo inizia così:
MARGHERITA
Oh, dimmelo, Enrico!
FAUST
Cosa c'è?
MARGHERITA
Dimmi, ecco: come stai tu a religione?
Tu sei l'uomo più buono che ci sia,
ma credo che non te ne importi molto.
FAUST
Lascia andare, bambina, tu senti che ti voglio bene;
a chi amo darei la vita e il sangue;
non porterei mai via chiesa e fede a nessuno.
MARGHERITA
Non va bene così, bisogna crederci!
FAUST
Bisogna?
MARGHERITA
Ah, se avessi un qualche potere su di te!
Non rispetti neppure i santi sacramenti.
FAUST
Io li rispetto.
MARGHERITA
Ma non li desideri!
Da quanto non vai a messa e ti confessi?
Credi in Dio?
FAUST
Carissima, chi oserà dire:
"Io credo in Dio"
Domandalo pure ai saggi o ai preti,
e la risposta sembrerà solo prendere in giro
chi ha domandato.
MARGHERITA
Allora tu non credi?
Non si può certo dire che la povera Margherita, che poi finirà sedotta e abbandonata, non sia abbastanza insistente con Faust. Ma nonostante il dialogo vada avanti ancora per un bel po', Margherita non riesce a tirare fuori neanche un ragno dalle risposte evasive dell'amato Faust.
E cosa ne pensava Goethe?
Chi facesse a Goethe questa stessa domanda "Dimmi, ecco: come stai tu a religione?" potrebbe trovarsi in difficoltà molto simili, perché Goethe, nelle varie fasi della sua lunga vita (muore a 83 anni), ha dato risposte molto diverse. Due testimonianze
di persone vicine a Goethe possano illustrarlo:
Non va a messa e prega raramente;
perché, come dice lui, "non sono
abbastanza bugiardo per farlo."
(Kestner)
Se Gesù avesse incontrato Goethe,
avrebbe trovato in lui l'amico più caro.
(Barnhagen)
Delle volte Goethe usa parole molto dure e sarcastiche parlando anche di contenuti sacri della fede cristiana. Una volta, p.e., osservando un quadro religioso che rappresentava la tomba aperta e vuota di Gesù, esclama:
"La tomba è aperta, che miracolo meraviglioso!
Beato chi ci crede. Imbroglioni, lo avete portato via!"
Altre volte si esprime con parole di stima sull'importante ruolo morale e sociale del cristianesimo.
Una contradizione? No.
Goethe è una persona senz'altro religiosa, per tutta la sua vita si occupa di religione e anche le sue opere sono piene di riflessioni sull'argomento. Si
occupa intensamente non solo della religione cristiana, nelle sue espressioni del cattolicesimo e del protestantesimo, ma anche dell'islam e di altre religioni asiatiche, un interesse certamente singolare per l'epoca in cui visse.
Nel marzo del 1831, quando ha ormai 82 anni e sta riflettendo su tutti gli sforzi compiuti per arrivare a una visione armonica del mondo, scrive all'amico Sulpiz Boisserée:
"In tutta la mia vita non ho trovato nessuna fede
che mi convinceva al punto di poter aderirne".
Nelle numerose esternazioni di Goethe sulla religione in generale, su Dio e sul cristianesimo in particolare, che delle volte possono anche sembrare contraddittorie, c'è invece un filo rosso.
Goethe e la natura:
Questo filo rosso è il rapporto di Goethe con la natura che nel corso della sua lunga vita si modifica, ma non cambia radicalmente.
Fin da giovane Goethe cerca la vera religione e la trova nella natura. Molto presto si convince "di vedere Dio nella natura e la natura in Dio". Dio e natura
sono per lui concetti equivalenti; la natura possiede, secondo lui, volontà, ragione, saggezza, bontà e amore.
Nel corso della sua vita Goethe sviluppa idee pansofistiche e panteistiche che identificano Dio con tutto l'esistente. Queste sono certamente convinzioni che si trovano in netta contrapposizione sia con la fede protestante che con quella cattolica. Per questo, e per altri motivi che vedremo più avanti, Goethe si vede spesso confrontato con il rimprovero di essere un ateo. Ma
in qualunque modo lo chiamino, panteista, ateo o cristiano, per Goethe è indifferente, tanto "nessuno sa veramente cosa questi concetti possano significare". La religione
è per Goethe un sentimento strettamente privato, individuale, parlarne troppo non gli piace.
Nel gennaio del 1813 scrive:
"Come poeta e artista sono politeista, come ricercatore della natura sono panteista, sono entrambe le cose con assoluta convinzione."
Infanzia e gioventù a Francoforte (1749-1765):
Johann Wolfgang Goethe nasce nel
1749 a
Francoforte. Francoforte è, a quell'epoca, una
città protestante e i genitori del piccolo Johann Wolfgang ci tengono
molto alla loro fede religiosa. Così Goethe riceve una educazione religiosa (da un insegnante privato) che
ha una profonda influenza sulla sua formazione. L'insegnante stimola Goethe a un intenso studio della Bibbia e della lingua ebraica, e l'ottima conoscenza delle storie della Bibbia, in particolare quelle del Vecchio Testamento, si riflette in molte opere sia del giovane che del maturo Goethe.
Ma proprio questo continuo confronto con la Bibbia porta Goethe fin da giovane, ai primi dubbi sull'interpretazione della Bibbia da parte della gerarchia protestante.
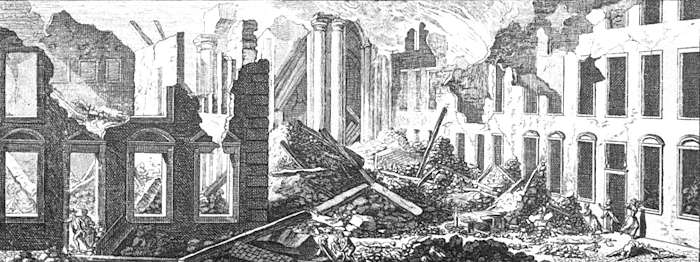 Lisbona dopo il terremoto del 1755
Lisbona dopo il terremoto del 1755
disegno di Daniel Chodowiecki (1774)
fonte:
Wikimedia Commons
Una prima scossa è rappresentata dal terribile
terremoto di Lisbona nel 1755.
Questo terremoto colpisce una vastissima area ma in particolare Lisbona dove
si contano tra 60.000 e 90.000 morti, ma persino in Marocco si hanno altri
10.000 morti. Questo evento ha in tutta l'Europa, tra teologi e filosofi, una enorme risonanza, dai tentativi di trovare consolazione
per l'immane tragedia, alle giustificazioni come castigo di Dio. Anche il
mito della "buona natura" evocato dal filosofo illuminista Rousseau riceve
un duro colpo. Di queste discussioni anche il piccolo Goethe sente parlare. Nella sua autobiografia Goethe descrive dettagliatamente come la sua concezione di un Dio paterno e saggio fu messa seriamente in crisi: l'idea di un Dio rabbioso e permaloso che punisce indifferentemente peccatori e giusti lo scosse profondamente.
Goethe continua a cercare la risposta alle sue domande nella Bibbia e, di fronte alle evidenti contraddizioni nei vari testi biblici, il suo insegnante di ebraico, Albrecht, lo indirizza
sempre più spesso a uno dei libri nella sua biblioteca che conteneva le
interpretazioni della Bibbia dei più accreditati teologi dell'epoca. Così
Goethe capisce che la Bibbia, che ama molto, non è una fonte indiscussa di verità. La sicurezza di fede ostentata dalla chiesa protestante non
risulta più sufficiente per lui e non lo rassicura più perché non dà risposte soddisfacenti al crescente disagio creato dall'apparente incompatibilità tra fede e ragione nel giovane Goethe.
Gli anni all'università, a Lipsia e a Strasburgo (1765-1771):
Nel 1765 Goethe viene mandato all'università di Lipsia per studiare
giurisprudenza. Rispetto a Francoforte che, alla fine del '700,
è una città piccola, stretta e provinciale, a Lipsia si respira un'aria diversa. Soprattutto grazie alla sua prestigiosa università Lipsia
è una città aperta, influenzata anche profondamente dalla
corrente filosofica dell'illuminismo e dal pietismo, una corrente del protestantesimo sorta in polemica con il luteranesimo istituzionale, ostile ai dogmi e alla ricerca di una religiosità interiore strettamente individuale. Con gli amici Goethe discute intensamente tutte le questioni di teologia, filosofia, estetica, società e psicologia che
sono nell'aria in quel periodo. A Lipsia il giovane Goethe si sente molto attratto dal pietismo e si fa
coinvolgere molto senza però trovare la soddisfazione che cerca.
Ora Goethe comincia a formare coscientemente la "sua religione" e a
Strasburgo, la città dove finisce i suoi studi,
riceve molti nuovi stimoli per farlo. Qui conosce alcuni scrittori della nuova corrente letteraria dello "Sturm und Drang", in particolare
Johann Gottfried Herder dal quale Goethe
è fortemente stimolato sia nella sua poesia sia nel suo sentimento religioso. Herder invita Goethe allo studio del Corano e gli dà una nuova visione storico-critico della Bibbia. In quegli anni, la protesta del giovane Goethe, che
è alla ricerca di una indipendenza spirituale, contro tutte le restrizioni ortodosse e pietistiche si
fa sempre più forte. Trova infine un nuovo accesso alla religione, a partire dal 1773, nel
pantheismus di Spinoza, che vede Dio in tutte le manifestazioni della natura.
"La religione naturale, in realtà, non ha bisogno di una fede, poiché la convinzione, che dietro la natura si nasconda un grande essere creatore che ordina e guida, una tale convinzione è evidente a tutti", scrive nella sua autobiografia sul risultato della sua ricerca religiosa in quell'epoca. Secondo lui ognuno
ha il diritto di cercare un proprio, individuale accesso alla religiosità.
La sua prima tesi sui Dieci Comandamenti che consegna all'università di
Strasburgo viene respinta. Purtroppo l'originale è andata perduta, si conosce il suo contenuto solo attraverso le critiche dei professori che
sono scioccati da tanta "stupidaggine religiosa". Il secondo tentativo di Goethe di finire finalmente i suoi studi di giurisprudenza, la tesi "De Legislatoribus", sul rapporto tra stato e chiesa
è invece accettata, ma la sua stampa viene rifiutata. Evidentemente i professori di Strasburgo
vogliono solo disfarsi di uno studente troppo anticonformista.
La produzione letteraria di Goethe fino al trasferimento a Weimar (1775):
La ricca produzione letteraria di Goethe del periodo tra il 1770 e il 1775
riflette sia la sua intima conoscenza della Bibbia e delle correnti
filosofiche e religiose dell'epoca, sia la sua ricerca di una sua
religiosità personale.
Ritroviamo nelle sue opere del periodo sia il
pluralismo e la
tolleranza
religiosa dell'illuminismo che la forte esasperazione del ruolo del "genio"
dello "Sturm und Drang", cioè del individuo che non tollera né regole né
restrizioni.
La "
Lettera del pastore di *** al nuovo pastore di ***", pubblicato in modo
anonimo nel
1772, contiene una frase che rimarrà significativa per tutta la
vita di Goethe:
"Che gioia è immaginare che il turco,
che oggi mi disprezza come cane,
e l'ebreo, che mi considera un maiale,
un giorno saranno felici di chiamarsi
fratelli miei."
Questa lettera fa capire che Goethe non ha nessuna simpatia
per una delle confessioni religiose, ma che, d'altra parte, ritiene
essenziale lo spirito religioso e la ricerca di un senso generale della vita
che non esita a chiamare "divino". Goethe rifiuta ogni dogma da parte
protestante e cattolica, ma è molto aperto alla spiritualità religiosa in
generale.
Un ultimo esempio del suo sentire religioso in quel periodo è l'inno
"
Prometeo" del
1773. Qui Goethe sfida apertamente Dio e si mette al suo
stesso livello. Questa poesia, nel tipico stile dello Sturm und Drang,
rivela la sua forte tendenza all'autoaffermazione e all'indipendenza nei
confronti di Giove (cioè Dio), visto che qui il protagonista Prometeo (cioè
Goethe) parla in prima
persona. L'ultimo orgoglioso manifesto di
Prometeo nei confronti di Dio è:
"Io sto qui e creo uomini
a mia immagine e somiglianza,
una stirpe simile a me,
fatta per soffrire e per piangere,
per godere e per gioire,
e per non curarsi di te,
come me."
Ma oltre a sfidare Giove Prometeo riconosce dei poteri che stanno ancora più
in alto di Giove:
"Io renderti onore? E perché?
Non mi fecero uomo
il tempo onnipotente
e l'eterno destino,
i miei padroni e i tuoi?"
Quindi, Prometeo si oppone contro un Dio dispotico che vuole imporgli la sua
volontà. Ma al di sopra di quel Dio sta "il divino", cioè il tempo
onnipotente e l'eterno destino. Ed è a quel carattere divino che Prometeo (e
con lui Goethe) si sente legato.
I primi anni a Weimar:
Con il suo trasferimento a Weimer finisce definitivamente la fase
"sturmeriana" di Goethe, ora si trova in un ambiente di corte con la sua
vita mondana e Goethe si adatta velocemente. È questo il periodo della vita
in cui Goethe si allontana maggiormente dalla religione.
Ma allo stesso tempo si avvicina al mondo dell'antichità greco-romana. È
attirato dalla loro inclusione del carattere divino nella natura e nel mondo
degli uomini cosa che corrisponde al suo modo di pensare. L'antichità
fornisce ora i nuovi modelli e il mondo antico degli Dei diventa un motivo
ricorrente nelle sue poesie.
Nell'antichità riconosce una forma umana e allo stesso tempo religiosa del
paganesimo. Espressione di questa nuova visione sono gli inni "Limiti
dell'umano" (Grenzen der Menscheit, 1778) e "Il divino" (Das Göttliche,
1783).
Il viaggio in Italia:
Nel periodo dell'infanzia e della gioventù a Francoforte Goethe vive in un
ambiente protestante. Durante gli studi universitari a Strasburgo conosce
per la prima volta il cattolicesimo e alcuni dei suoi rappresentanti, solo
durante il viaggio in Italia (1786-1788) Goethe vive, per così dire "in
piena immersione" il mondo cattolico con i tutti i suoi rituali e le sue
credenze. Per conoscere a fondo l'Italia e gli italiani, Goethe accetta
volentieri questo coinvolgimento: "Se uno volesse vivere qui dovrebbe
diventare cattolico, per poter partecipare pienamente alla vita di questi
uomini" scrive nel suo diario di viaggio.
La simpatia verso una vita quotidiana
improntata dal cattolicesimo che Goethe esprime varie volte nel suo diario
non significa però un avvicinamento al mondo cattolico o addirittura una
conversione vera e propria. Piuttosto sfrutta questa consapevole immersione
nella vita cattolica come mezzo per avvicinarsi all'Italia e agli italiani,
per l'ampliamento della sua immagine del mondo. "Dappertutto ho saputo
trovare e stimare il bene" scrisse in "Wilhelm Meisters Wanderjahre" e le
sue esperienze durante il viaggio in Italia ne sono una testimonianza.
Ma le sue esperienze italiane con il cattolicesimo sono contraddittorie: da
una parte Goethe loda "la dignità delle cerimonie papali" in San Pietro e
quando ha l'occasione di assistere ai canti della liturgia del Venerdì Santo
confessa: "In quel momento avrei voluto essere un
bambino o un credente".
Dall'altra parte si rafforzano le sue avversioni contro la credenza nei
miracoli e la venerazione delle reliquie, dei martiri e dei santi. Dei santi
si salva solo Filippo Neri, al quale Goethe dedica addirittura una breve biografia con il titolo significativo "Philipp Neri, der
humoristische Heilige" (Filippo Neri, il santo spiritoso), sottolineando
così, attraverso il carattere coerente e umano del protagonista, la sua
diversità che per Goethe lo fa diventare un uomo (non un santo!) da
ammirare.
Il Faust:
Il Faust è l'opera più famosa di Goethe ed è anche l'opera della sua vita:
dai primi frammenti al termine della seconda parte dell'opera passano
60
anni, in cui si susseguono varie versioni che riflettono la sua continua
riflessione sulle religioni.
L'opera è piena di citazioni dalla Bibbia che Goethe conosce bene e i
riferimenti a Dio e il diavolo sono continui. Già nel prologo vediamo Dio e
il diavolo coinvolti in una amichevole conversazione in cui, alla fine, il
diavolo descrive Dio - in modo piuttosto blasfemo - come "un vecchio
signore simpatico con cui è piacevole chiacchierare" e anche l'idea di base,
la scommessa tra Dio e il diavolo è presa dalla Bibbia, più precisamente dal
libro di Giobbe.
Per Goethe Dio si identifica con vita, movimento, azione, temi centrali
dell'opera. E così Faust traduce l'inizio del vangelo di Giovanni così:
"All'inizio fu l'azione." Goethe pone il cristianesimo dell'azione contro
quello della confessione.
L'anziano Goethe:
Negli ultimi venti anni della sua vita Goethe tende sempre di più ad
unire
le contraddizioni: Dio e il mondo, lo spirito e la natura, l'idea e la
materia, l'individuo e la società. Gli estremi si devono unire a un livello
più alto. Per lui il posto di Dio è nel mondo, così come l'uomo può
raggiungere caratteristiche che lo avvicinano a Dio.
Per il concetto della fede individuale Goethe arriva persino a una
interpretazione psicologica che sembra piuttosto moderna: "Per quanto
riguarda la fede, l'unica cosa che conta è che si creda. Ciò a cui si crede
è del tutto indifferente". Per Goethe la fede non è altro che un grande
sentimento di sicurezza che si basa sulla fiducia in un essere
imperscrutabile, più grande e potente di noi.
Si occupa anche approfonditamente delle altre grandi religioni,
dell'Ebraismo, dell'Islam e anche dell'Induismo. Solo la somma di queste
religioni poteva, per Goethe, rappresentare la base per una metafisica
spirituale.
Undici giorni prima della sua morte Goethe riassume, in una conversazione su
argomenti religiosi con il suo segretario Eckermann: "Se mi si chiede se
sono disposto a esprimere il mio più profondo rispetto per la persona di
Cristo rispondo: certamente. Ma se mi si chiede di inchinarmi davanti alle
ossa del pollice dell'apostolo Pietro o Paolo, rispondo: statemi lontani con
tali assurdità".
Principi religiosi nella vita privata di Goethe:
Se non era costretto per cerimonie ufficiali Goethe non andava mai in
chiesa. Rimane lontano dall'istituzione della chiesa per tutta la vita,
anche se rispetta, per gli altri, i riti religiosi. Fece battezzare i suoi
figli e non ebbe niente da obbiettare contro un funerale religioso per sua
moglie. Non ha mai rotto pubblicamente con la chiesa. Ma le sue regole gli
erano estranee. Nella città di Weimar e nella sua piccola corte la vita
privata di Goethe ha destato scandalo più di una volta. Per diciotto anni
lui e Christiane Vulpius convivono in una casa e hanno dei figli - senza
essere sposati - e Goethe tratta Christiane come se fosse una moglie
legittima. Alla fine si sposano quando Goethe, per l'invasione dell'esercito
francese, teme per la sua vita e per quella di Christiane, per garantirle
una vita dignitosa anche dopo la sua morte.
Goethe era una persona profondamente religiosa, ma la sua religione aveva
poco a che fare con la religione protestante o cattolica. Era la sua
religione e Goethe era convinto che ognuno doveva avere la sua versione
individuale di vita religiosa, comunque strettamente privata.
Altre pagine su Goethe:
Vedi anche:
-
La letteratura tedesca del medioevo
Walter von der Vogelweide,
Wolfram von Eschenbach,
e "I Nibelunghi"
-
La letteratura tedesca 1750 - 1850
Lessing, Goethe, Schiller, Kleist,
Hoffmann, Heine,
Hoffmannsthal e altri
-
La letteratura tedesca 1850 - 1950
Fontane,
Thomas Mann, Schnitzler, Hesse,
Kafka, Brecht,
Musil, Rilke e altri
-
La letteratura tedesca dopo il 1950
Böll, Grass, Dürrenmatt,
Delius, Ransmayr, Wolf,
Kunze e altri
Potrebbero interessarti anche:
© 2025 Wolfgang Pruscha
Termini e condizioni di utilizzo del sito

