Friedrich Schiller: "Storia della guerra dei Trent'anni"
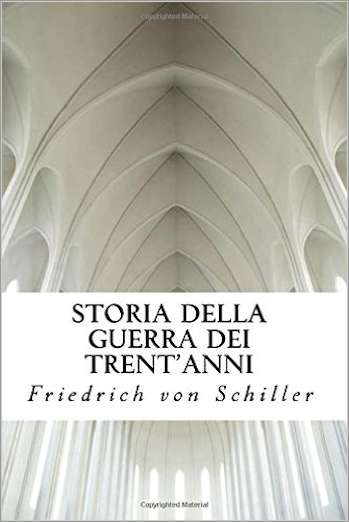 La copertina del libro
La copertina del libro
Friedrich Schiller come storico:
Alla voce "Schiller, Friedrich" le enciclopedie ci
dicono di solito "Poeta e drammaturgo tedesco". Del fatto che Schiller è
stato anche uno storico parlano relativamente poco, eppure Schiller è stato
probabilmente il più famoso storico della sua epoca. Ricordarsene è
importante non solo perché quasi tutta la sua produzione drammaturgica fa
riferimento a persone ed eventi storiche, p.e. "
La Congiura di Fiesco a
Genova", "
Don Carlos", "
Wallenstein", "
Maria Stuart" e "
La Pulzella
d'Orléans". Per alcuni anni della sua breve vita Schiller si occupò quasi
esclusivamente di ricerche storiche, fece lezioni di storia all'università
di Jena e pubblicò due ricerche importanti: "
Storia della rivoluzione dei
Paesi Bassi sotto il regno di Fillippo II" e soprattutto "
Storia della
guerra dei Trentanni" che all'epoca fu un grande successo editoriale.
Occuparsi di storia è stato molto importante per Schiller, per parecchi anni
fu anche l'unica cosa che gli poteva garantire un certo reddito, importante
per uno scrittore sposato e con figli che per quasi tutta la sua vita si trovò in condizioni
economiche piuttosto difficili (
vedi
la biografia di Schiller). Ma c'è molto di più. In una lettera del 18
gennaio 1788
confessò al suo amico Körner: "Alla fine di un libro storico ho ampliato le
mie idee e ne ho ricevuto delle nuove - alla fine di una terminata opera
teatrale invece ne ho perso alcune." Le ricerche sulla psicologia dei
personaggi della storia sono per Schiller un campo molto fertile che
arricchisce la sua fantasia poetica.
Nelle sue opere storiche Schiller cercò scrupolosamente "la verità storica",
pur sapendo che ogni storiografia è sempre interpretazione delle fonti che
spesso sono scarse e non sempre affidabili.
Schiller rifiutò categoricamente un punto di vista "nazionale" del racconto
storico che per lui, che si considerò, come Goethe, "cittadino del mondo",
era insopportabile. Quello che, all'epoca, rese
particolarmente apprezzati i suoi libri sulla storia fu l'unione tra la passione
per la storia e un'imparzialità del punto di vista,
la precisione dei ritratti psicologici dei protagonisti e, non ultimo,
lo stile letterario piacevole ed elegante del racconto storico.
Dall'altra parte, nelle sue opere teatrali, Schiller usò la storia in
maniera piuttosto disinvolta: personaggi ed eventi dovevano piegarsi alle
esigenze del dramma. Ma per Schiller non si trattava di una contraddizione:
la "verità" di un testo letterario e quella di una ricerca storica avevano,
per Schiller, lo stesso valore, ma compiti diversi.
La "Storia della guerra dei Trent'anni" di Schiller:
Già nelle prime pagine dell'opera si scopre la sorprendente modernità del testo di
Schiller quando parla del ruolo del fanatismo religioso che costituì una
componente decisiva in quella guerra:
"Ciò che il pericolo più determinante per lo stato non aveva potuto sui
cittadini fu reso possibile dall'entusiasmo religioso. Per l'interesse dello
stato e del sovrano ben poche braccia si sarebbero armate volontariamente;
per la religione, artisti, commercianti, coltivatori fecero a gara per
arruolarsi. Per l'interesse dello stato e del principe, anche la minima
tassa straordinaria appariva alla gente troppo pesante, per la religione
sacrificavano con gioia la loro vita e tutti i loro beni. Somme immense
alimentarono la finanza pubblica e i volontari ingrossarono incessantemente
i ranghi dell'armata. L'esaltazione era tale che si percepivano appena
sacrifìci che in tempi normali sarebbe stati considerati impossibili" (pag.
12).
Ma dall'altra parte Schiller sa benissimo che gli interessi religiosi da
soli non avrebbero potuto scatenare un'inferno tale come quella guerra:
"Se gli interessi privati e quelli pubblici non si fossero sovrapposti, né
la voce dei teologi né quella delle genti avrebbero trovato dei principi
così disponibili ad ascoltarle; mai nuove dottrine (Schiller si riferisce
qui alle idee della Riforma di Lutero) avrebbero armato tanto zelo e tanti
valenti difensori. (...) Anche se non si può negare che l'amore per
l'indipendenza e la prospettiva del ricco bottino che prometteva
l'appropriazione dei monasteri e delle abbazie, accrescesse, agli occhi di
molti principi, il merito delle dottrine di Luterò, per deciderli a
difendere apertamente queste dottrine era necessario che la ragion di stato
ne facesse per loro un dovere" (pag.8). Schiller non nega mai le sue simpatie per la
parte protestante, ma vede chiaramente che la religione, in quella guerra,
fu strumentalizzata da tutte le parti. Mentre per molti partecipanti la
guerra pro o contro l'Imperatore (= pro o contro il potere della Chiesa
cattolica) fu una questione di cuore e di convinzione, per i principi che
manovravano gli eserciti, la religione rimase sempre un mezzo di potere.
Schiller vide in quella guerra il primo conflitto a livello europeo che alla
fine, nella Pace di Vestfalia, portò l'Europa devastata a una nuova
consapevolezza: che gli stati dell'Europa costituivano una comunità e che
una guerra come questa, che aveva dimezzato la popolazione dell'Europa
centrale, non doveva mai più succedere. Qui Schiller peccava senz'altro di
ottimismo: quando scrisse quell'opera non conosceva ancora le conseguenze
devastanti che avrebbe avuto la rivoluzione francese per gli stati europei,
per non parlare delle terribili guerre del ventesimo secolo. Ma questo non
diminuisce certo il valore di questa ricerca voluminosa (ca. 400 pagine). È
del tutto normale che un testo storico come quello di Schiller, scritto più
di 200 anni fa, contenga delle valutazioni superate, dovute anche alla
disponibilità di certe fonti storiche che Schiller non aveva a disposizione. Ma
l'abbondante apparato critico dell'editore fornisce in ogni caso le
precisazioni necessarie e dà al lettore una grande quantità di ulteriori
informazioni, soprattutto sui personaggi citati che il lettore di oggi,
anche quello con una solida preparazione storica, difficilmente può
conoscere.
Vale la pena leggere i libri storici di Schiller ancora oggi? Senza dubbio,
sia per chi si interessa di storia che per colui che apprezza soprattutto
gli scritti letterari di Schiller: la sua ricerca sulla guerra dei
Trent'anni è tuttora citata e considerata importante nelle monografie
storiche dedicate a quell'epoca e Rüdiger Safranski scrive nella sua celebre
biografia di Schiller: "Per quanto riguarda la bellezza letteraria del
racconto, lo storico Schiller è rimasto, fin ad oggi, insuperato".
Per ordinare il libro:
Argomenti correlati:
Le epoche della letteratura tedesca:
-
La letteratura tedesca del medioevo
Walter von der Vogelweide,
Wolfram von Eschenbach,
e "I Nibelunghi"
-
La letteratura tedesca 1750 - 1850
Lessing, Goethe, Schiller, Kleist,
Hoffmann, Heine,
Hoffmannsthal e altri
-
La letteratura tedesca 1850 - 1950
Fontane,
Thomas Mann, Schnitzler, Hesse,
Kafka, Brecht,
Musil, Rilke e altri
-
La letteratura tedesca dopo il 1950
Böll, Grass, Dürrenmatt,
Delius, Ransmayr, Wolf,
Kunze e altri
Potrebbero interessarti anche:
© 2025 Wolfgang Pruscha
Termini e condizioni di utilizzo del sito
