Karl Marx
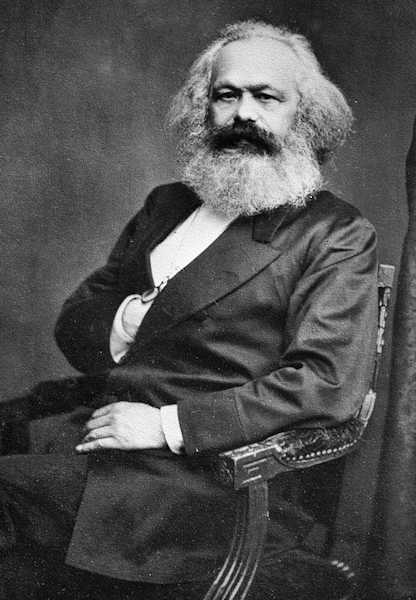 Karl Marx (1818-1883), in una fotografia del 1875
Karl Marx (1818-1883), in una fotografia del 1875
foto:
John Mayal
La vita di Karl Marx:
Karl Marx nacque a Treviri il 5 maggio 1818.
Figlio di un brillante avvocato ebreo che, insieme con la famiglia, si era
convertito al protestantesimo per motivi politici, nonostante fosse rimasto
su posizioni sostanzialmente agnostiche, Marx ebbe un'educazione improntata
al liberalismo ed in un primo momento pensò di seguire la carriera paterna
iscrivendosi a Giurisprudenza.
A Berlino, però, il contatto con il club
dei Giovani Hegeliani (dei quali in seguito rinnegherà le posizioni) e
con il pensiero di Hegel, lo portarono a maturare la decisione di
abbandonare Legge e di iniziare a frequentare la
facoltà di filosofia a Jena,
dove si laureò con una tesi su Democrito ed Epicuro.
Data la politica reazionaria vigente in Prussia, decise che le sue posizioni
politiche non gli avrebbero permesso di intraprendere serenamente la
carriera universitaria e così divenne caporedattore della
Rheinische Zeitung (Gazzetta Renana), che
fu in seguito interdetta dal governo. Proprio a causa dello scioglimento
forzato del giornale, Marx fu costretto a trasferirsi a
Parigi (1843), dove terminò la stesura
della Critica della filosofia del diritto di Hegel. Il
1844 fu l'anno in cui Marx abbracciò
definitivamente l'ideologia comunista: ne
sono testimoni i 2 saggi che pubblicò sul primo (e ultimo) numero degli
Annali franco-tedeschi, redatto insieme con Ruge.
Sempre nel '44 Marx strinse una profonda amicizia con
Friedrich Engels e con lui cominciò ad
interessarsi alle materie economiche, un interesse che sfociò nei
Manoscritti economico-filosofici. Il
soggiorno francese non durò comunque oltre: sotto la pressione del governo
prussiano, Marx fu costretto ad abbandonare Parigi e si stabilì a
Bruxelles. Qui, in collaborazione con
Engels, scrisse Die heilige Familie (La Sacra Famiglia), diretta contro
Bauer ed i suoi discepoli, e maturò il definitivo distacco dalla filosofia
tedesca con le Tesi su Feuerbach e,
soprattutto, con Deutsche Ideologie
(Ideologia tedesca).
Nel 1848 la
Lega dei comunisti, al cui primo congresso del 1847 Marx non aveva
potuto partecipare, gli propose di stendere un documento
teorico-programmatico: il frutto di questo lavoro fu
Manifest der kommunistischen Partei (il
Manifesto del partito comunista), edito a Londra
sempre in collaborazione con Engels. Ristabilitosi nel frattempo in
Germania, Marx ne fu nuovamente espulso nel '49 e questa volta si trasferì a
Londra, dove si ritirò dalla politica
attiva dopo aver tentato di ricostituire la Lega dei comunisti.
Per Marx, la moglie Jenny e la loro numerosa famiglia, il soggiorno inglese
si presentò carico di problemi economici: il suo lavoro al British Museum e
la sua collaborazione col New York Tribune non sarebbero stati sufficienti
al sostentamento se non fossero arrivati aiuti da Engels. Ciò nonostante
Marx non interruppe la sua attività di studio e, nel 1866, iniziò a comporre
Das Kapital (il Capitale), che, dopo la
sua morte, fu redatto da Engels, il quale si basò sui suoi appunti.
Nel frattempo (1864) era diventato la
figura dominante dell'Associazione Internazionale
dei Lavoratori, per la quale, nel 1870,
scrisse due Indirizzi sulla guerra franco-prussiana. Del 1875 sono gli
Appunti sul programma di Bakunin Stato e Anarchia
e la Critica del programma di Gotha, una
disanima nei confronti della decisione di unificazione dei socialisti
tedeschi, per Marx poco rivoluzionaria. Nel 1881 gli morì la moglie Jenny e
Marx la seguì 2 anni dopo (il 14 marzo 1883),
lasciando nello sconforto Engels e tutto il movimento operaio
internazionale.
Il pensiero di Marx:
Nel 1858, lavorando al suo primo importante saggio di economia, Per la
critica dell'economia politica, Marx così descrive questa prima fase del suo
processo di formazione:
«Avevo cominciato lo studio di questa scienza a Parigi, e lo continuai a
Bruxelles, dove ero emigrato in seguito a un decreto di espulsione del sig.
Guizot. Il risultato generale al quale arrivai e che, una volta acquisito,
mi servì da filo conduttore nei miei studi, può essere brevemente formulato
così: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in
rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in
rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo
delle forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione
costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla
quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale
corrispondono forme determinate della coscienza sociale.»
Struttura - sovrastruttura: è una delle più importanti formulazioni marxiane
in ambito teoretico, ciò che fa di questo pensatore un filosofo a pieno
titolo. Questa coppia di concetti, infatti, può essere letta, nel solco
della tradizione "metafisica" occidentale, come la continuazione di quella
ricerca del fondamento che caratterizza tutta la storia della filosofia. In
questo caso, si tratta di un vero e proprio ribaltamento prospettico, che
pone la sostanza dell'esistenza non più "nel pensiero" degli uomini ma nella
loro natura materiale, determinata dal lavoro e dai rapporti di produzione.
Ma anche se la concezione idealista e metafisica tradizionale è ribaltata,
ciò non toglie che il concetto di "fondamento reale" o "incondizionato" con
cui Marx interpreta il ruolo dell'economia nei rapporti umani e
nell'esistenza, risponda al medesimo interrogativo sull'"essere" dell'uomo
che aveva da sempre guidato la ricerca filosofica.
«Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il
processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli
uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere
sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo,
la forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i
rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne
sono soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze per
l'innanzi s'erano mosse.»
I rapporti di proprietà costituiscono, nell'analisi economica marxiana,
l'elemento centrale del rapporto di forza tra le classi. Occorre chiarire
che, per Marx, contrariamente che per altri "socialisti" e "utopisti" del
suo tempo, non è la proprietà in sé il fattore di ingiustizia sociale da
combattere, ma la proprietà dei mezzi di produzione quando è separata da chi
effettivamente li utilizza. In poche parole: il capitalista detiene le
macchine dell'opificio con cui produce la merce da cui ricava il suo
profitto; ma egli non lavora direttamente alle sue macchine, bensì impiega
una forza-lavoro salariata alla quale non è destinato il profitto ricavato
dal proprio lavoro ma solo una quota di esso (il salario), sufficiente al
proprio mantenimento fisico. Questa separazione tra forza-lavoro
(proletariato) e mezzi di produzione è l'anomalia sociale che genera, alla
lunga, le rivoluzioni.
«Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono
in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il
cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta
la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è
indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle
condizioni economiche della produzione che può essere constatato con la
precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche,
religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che
permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come
non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso, così non si
può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha
di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni
della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive
della società e i rapporti di produzione.»
Testo: Franco Gonzato
L'orazione funebre di Friedrich Engels:
"Il 14 marzo, alle due e quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare
la più grande mente dell'epoca nostra. [...] Così come Darwin ha scoperto la
legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello
sviluppo della storia umana [...].
Ma non è tutto. Marx ha anche
scoperto la legge peculiare dello sviluppo del moderno modo di produzione
capitalistico e della società borghese da esso generata. La scoperta del
plusvalore ha subitamente gettato un fascio di luce nell'oscurità in cui
brancolavano prima, in tutte le loro ricerche, tanto gli economisti borghesi
che i critici socialisti. [...] Per lui la scienza era una forza motrice
della storia, una forza rivoluzionaria. [...]
Marx era prima di tutto
un rivoluzionario. Era perciò l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo.
I governi, assoluti e repubblicani, lo espulsero; i borghesi, conservatori e
democratici radicali, lo coprirono a gara di calunnie. Egli sdegnò tutte
queste miserie, non prestò loro nessuna attenzione, e non rispose se non in
caso di estrema necessità. È morto venerato, amato, rimpianto da milioni di
compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere
siberiane sino alla California. E posso aggiungere senza timore: poteva
avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei
secoli, e così la sua opera!"
Argomento correlato:
 Friedrich Engels
Friedrich Engels
Amico e stretto collaboratore di Marx. Scrissero alcune opere insieme.
Per approfondire:
© 2025 Wolfgang Pruscha
Termini e condizioni di utilizzo del sito

 Friedrich Engels
Friedrich Engels